Trump abbassa i dazi al 15% sull’UE: tregua o strategia?
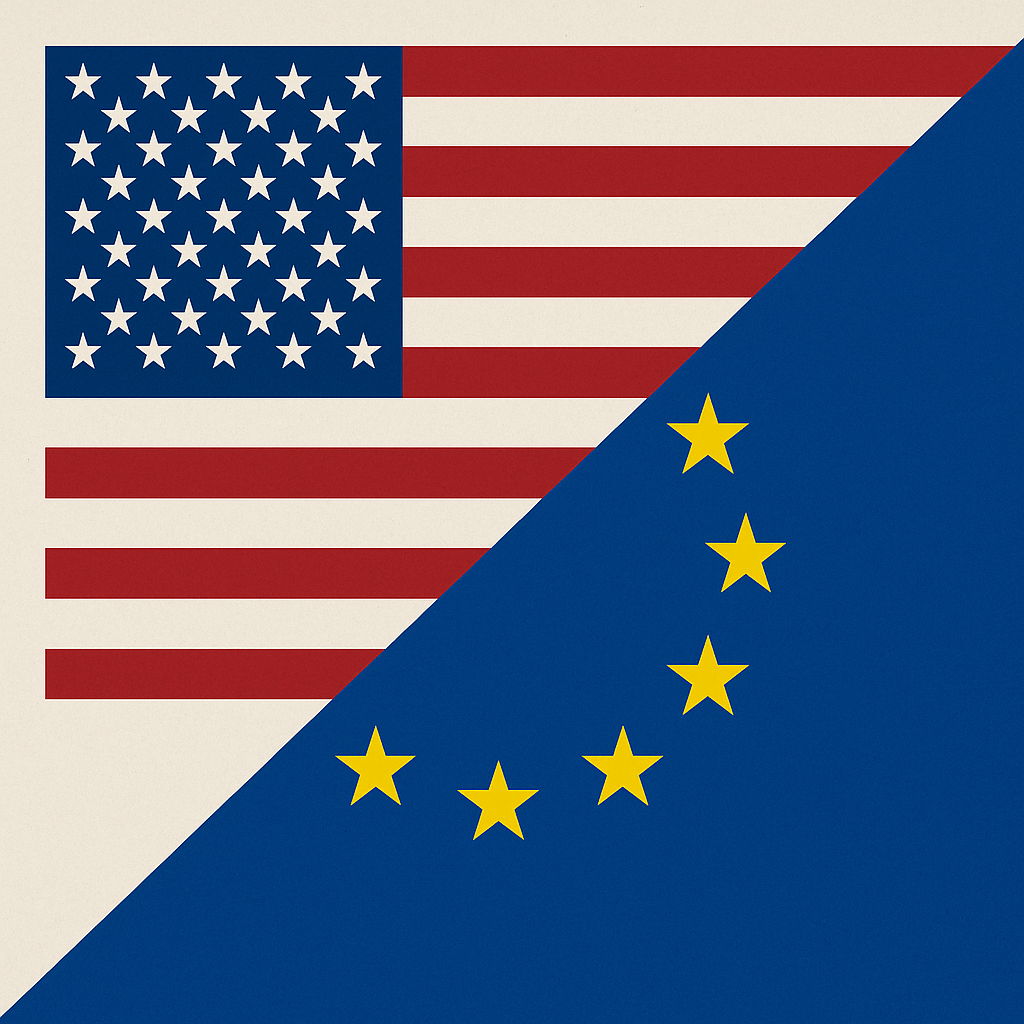
Il 1° agosto doveva essere il giorno dello strappo definitivo. La lettera inviata da Donald Trump all'Unione Europea era chiara: dazi al 30% su tutte le importazioni europee negli Stati Uniti. La misura appariva come l'apice di una guerra commerciale che aveva superato la dimensione tecnica per diventare sfida diplomatica, giuridica, geopolitica. E invece, nelle ultime ore, è arrivato un aggiornamento: il dazio sarà "solo" del 15%.
Una ritirata? Un gesto di distensione? Oppure una strategia più raffinata? La risposta non è immediata. La nuova aliquota non cancella lo scontro in atto: lo ridisegna. L'amministrazione Trump ha scelto di rallentare la corsa al protezionismo senza abbandonarne la logica. È ancora in vigore l'argomentazione della "sicurezza nazionale" come giustificazione giuridica per derogare alle regole del WTO. È ancora in campo il richiamo all'IEEPA, la legge federale che consente al presidente ampi margini d'azione in situazioni eccezionali. È ancora valida l'impostazione che fa del commercio non uno spazio di cooperazione, ma uno strumento di pressione.
A complicare ulteriormente lo scenario, c'è l'incertezza sulle aliquote finali. Nella nota trasmessa all'Unione Europea non sono stati pubblicati né gli elenchi definitivi dei beni colpiti né le tabelle tecniche con le percentuali settoriali. L'aliquota del 15% potrebbe quindi non essere uniforme, ma soggetta a modulazioni per tipologia di prodotto, Paese d'origine o livello tecnologico. Una variabilità che rende ancora più fragile la posizione contrattuale delle imprese esportatrici europee, già costrette a muoversi in un contesto di regole mutevoli e minaccia costante.
La differenza è solo quantitativa. Non più il 30%, ma il 15%. Eppure, l'effetto simbolico resta intatto. Perché è il principio a essere sotto attacco: quello di un sistema multilaterale basato su regole, reciproca fiducia e controllo giurisdizionale. L'Europa lo sa, e cerca ora di calibrare la sua risposta. Le contromisure annunciate – dazi su beni statunitensi per circa 70 miliardi di euro – sono per il momento congelate. Ma restano sul tavolo. Così come resta in discussione l'attivazione del meccanismo anti-coercizione, già evocato nei giorni successivi alla prima comunicazione di Washington.
Nel frattempo alcune cancellerie europee parlano di "de-escalation utile", mentre altre leggono la scelta di Trump come un movimento tattico in vista delle elezioni americane. E intanto i settori coinvolti – automotive, agroalimentare, farmaceutico, beni di lusso – continuano a fare i conti con la realtà: una realtà fatta di incertezza normativa, aumento dei costi, pressione sulle esportazioni, difficoltà nel mantenere la competitività in un quadro di regole sempre più fragili.
Ma la domanda vera è un'altra, più politica, più strutturale, più inquietante. È possibile immaginare un futuro per il commercio globale se le regole possono essere cambiate unilateralmente da chi ha più potere? Se la clausola della nazione più favorita viene piegata alla logica dell'interesse nazionale? Se le dispute non si risolvono più nei tribunali internazionali ma sui tavoli delle trattative forzate?
Trump non ha fatto marcia indietro. Ha soltanto rallentato la corsa. Per l'Europa è un'occasione. Non per adeguarsi, ma per reagire con visione. Serve una politica industriale comune, serve una strategia commerciale integrata, servono strumenti giuridici e diplomatici capaci di proteggere i settori strategici senza cedere alla tentazione di rispondere alla forza con altra forza.
Perché il diritto, quando è autentico, non risponde alla minaccia con la vendetta. Ma con un progetto.
