Carne coltivata: cos’è, cosa dice la legge italiana ed europea, sfide etiche e prospettive future
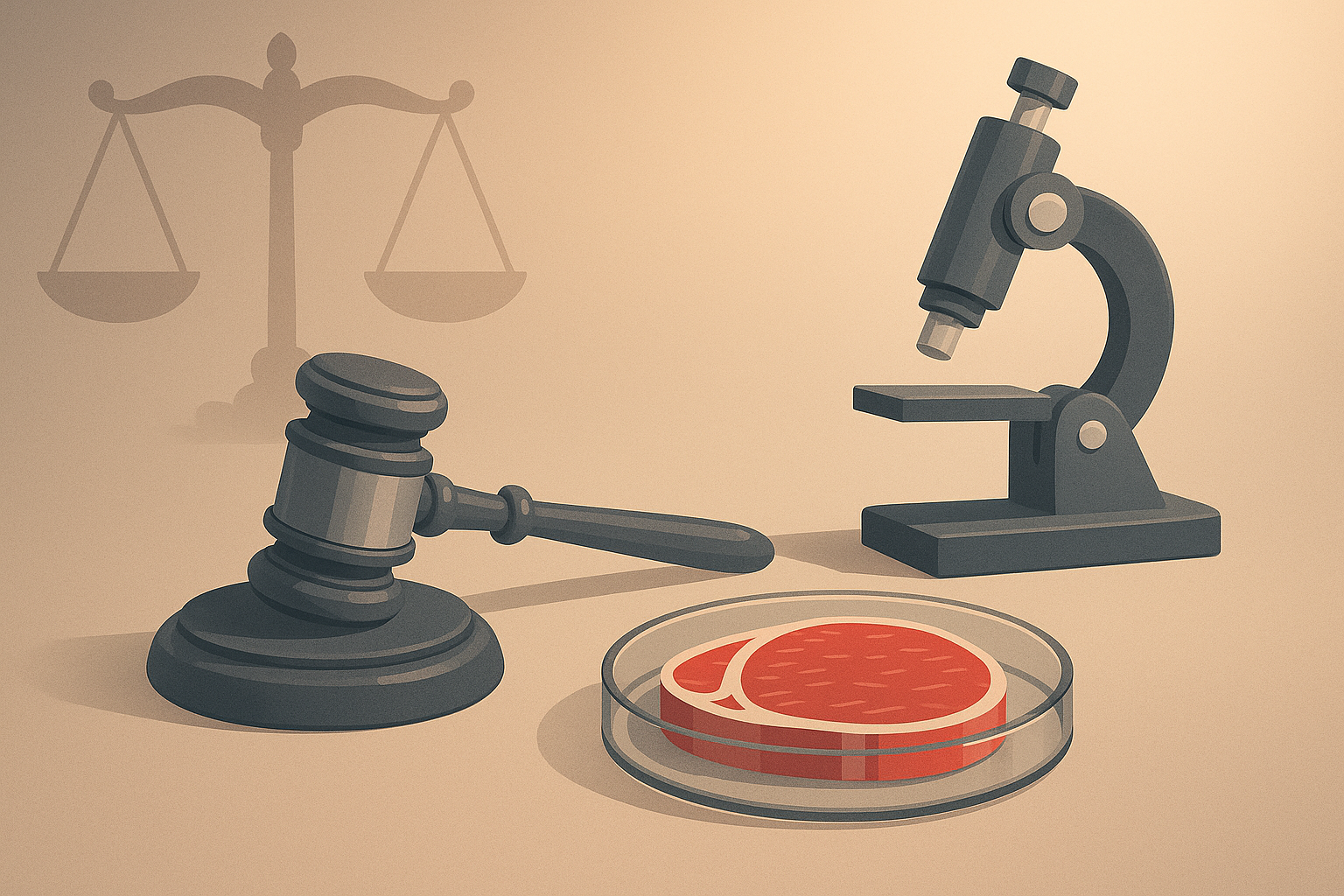
La carne coltivata è un prodotto alimentare ottenuto a partire da vere cellule animali fatte crescere e moltiplicare in laboratorio. Si tratta, dunque, non di un surrogato vegetale o di una replica artificiale della carne, ma di un tessuto muscolare biologicamente identico a quello animale, sviluppato in condizioni controllate e asettiche, attraverso l'impiego di biotecnologie cellulari. La sua produzione avviene prelevando cellule staminali da un animale vivo, senza necessità di macellazione, per poi nutrirle con apposite soluzioni contenenti fattori di crescita e nutrienti, fino a ottenere fibre muscolari strutturate. Il risultato finale si presenta, a tutti gli effetti, come carne, ma ottenuta in modo radicalmente diverso da quello tradizionale.
Questo tipo di innovazione è già realtà in alcuni contesti. Singapore è stato il primo Paese al mondo ad autorizzare, nel 2020, la vendita di carne coltivata, seguito da ulteriori iniziative in fase di approvazione in mercati come gli Stati Uniti. Tuttavia, nell'Unione Europea, la carne coltivata rientra nella categoria dei cosiddetti 'novel food', ossia "alimenti nuovi" non consumati in misura significativa prima del 1997, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2283. La sua eventuale commercializzazione nel territorio dell'Unione è subordinata a una complessa procedura autorizzativa, che implica una rigorosa valutazione scientifica da parte dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare limentare, seguita da un atto di autorizzazione della Commissione Europea. A oggi non è ancora disponibile alcun prodotto a base di carne coltivata autorizzato in UE, anche se alcune aziende hanno presentato domanda.
Nel contesto italiano, però, la prospettiva è radicalmente diversa. Nel 2023 il Parlamento ha approvato la legge 197 che vieta espressamente la produzione e la commercializzazione di carne coltivata sul territorio nazionale. La ratio del divieto, come dichiarato nei lavori parlamentari, si fonda su una molteplicità di esigenze: la tutela della salute pubblica, la salvaguardia della tradizione agroalimentare italiana, la protezione della cultura enogastronomica locale e il principio di precauzione. La legge ha suscitato ampio dibattito anche a livello accademico, in quanto solleva interrogativi sul piano della compatibilità con l'ordinamento europeo. Infatti, secondo il diritto dell'Unione, le restrizioni alla libera circolazione delle merci possono essere giustificate solo da motivazioni oggettive e proporzionate. Un divieto preventivo e assoluto, in assenza di evidenze scientifiche che dimostrino un rischio concreto per la salute, potrebbe risultare sproporzionato e potenzialmente censurabile in sede comunitaria.
Oltre al tema della liceità del divieto nazionale, la carne coltivata solleva una serie di problematiche giuridiche ancora aperte e non pienamente disciplinate. Innanzitutto, vi è il tema dell'etichettatura: come definire correttamente questo alimento affinché il consumatore riceva informazioni veritiere, trasparenti e non fuorvianti? È ammissibile l'uso della parola "carne"? O si tratta di un termine da riservare esclusivamente ai prodotti di origine animale ottenuti per macellazione? Ancora, si pongono questioni legate alla tutela dei diritti dei consumatori, che devono essere messi nelle condizioni di operare scelte alimentari consapevoli e basate su informazioni complete. Al tempo stesso, emerge l'esigenza di regolamentare l'intera filiera biotech, dalle cellule iniziali ai bioreattori, passando per i brevetti, i protocolli di sicurezza igienico-sanitaria ed i regimi di responsabilità in caso di difetti del prodotto.
L'approccio normativo richiesto non può essere né ideologico né approssimativo. Occorre un equilibrio delicato tra la promozione dell'innovazione tecnologica, la protezione della salute pubblica e la salvaguardia delle libertà economiche garantite dall'ordinamento. È essenziale che il legislatore operi in modo laico, basandosi su dati scientifici e sull'analisi del rischio, evitando derive protezionistiche o narrative identitarie che rischiano di ostacolare il progresso.
Sul piano più ampio, la carne coltivata apre una riflessione etica profonda. L'idea di poter produrre carne senza allevamento e macellazione pone interrogativi sul significato stesso di alimentazione, sulla relazione tra esseri umani ed animali, sulla sostenibilità ambientale e sull'impatto delle tecnologie sull'identità culturale. Se da un lato la coltivazione cellulare promette una riduzione significativa dell'impatto ambientale e delle emissioni rispetto all'allevamento intensivo, oltre a rispondere alle crescenti sensibilità verso il benessere animale, dall'altro lato essa potrebbe trasformare radicalmente le dinamiche economiche del settore agricolo, mettendo in crisi modelli produttivi tradizionali e occupazione.
Infine, le prospettive di sviluppo restano ampie, ma ancora incerte. Le biotecnologie alimentari rappresentano una delle frontiere più avanzate del diritto agroalimentare contemporaneo. Il compito del giurista è quello di accompagnare questo cambiamento con rigore tecnico, visione critica e consapevolezza etica, contribuendo a costruire un sistema normativo capace di governare l'innovazione, senza subirla, né reprimerla.
